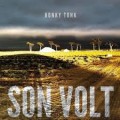2013: i dieci dischi dell’anno del Mascalzone
di Pierluigi Lucadei | in: in Vetrina, Play List1. Bill Callahan “Dream River”
Etichetta: Drag City
“Dream River” è una piccola meraviglia. Piccola perché contiene solo otto brani. Meraviglia perché, anche al netto di tutto ciò che l’ex Smog ha scritto, registrato e cantato in vent’anni di carriera, ognuno degli otto brani gode di propria e più che mai benefica luce. E’ il disco, questo va detto, meno immediato tra i quattro firmati da Bill Callahan col proprio nome. Occorre concedere tempo e dedizione al menestrello del Maryland, ma la ricompensa, potete starne certi, arriva. Prendete Javelin Unlanding, per esempio, con il suo flauto e il suo andamento da scanzonata marcetta: i primi due ascolti possono anche non colpire al cuore, ma dal terzo in poi non riuscirete più a farne a meno. “Dream River” si insinuerà dentro di voi subdolamente. Lo farà con musica cameristica della più sublime specie (Small Plane), con una ciondolante ballata venata di elettricità (Spring), con un giro di chitarra lento e ossessivo che introduce una bossanova malata e schizzata (Ride My Arrow). Per non parlare di The Sing e di Winter Road, poste rispettivamente in apertura e in chiusura di “Dream River”. La prima è un’atipica canzone da bar, con un testo caustico e geniale («looking out a window that isn’t there/looking at the carpet and the chairs/well the only words I said today are ‘beer’ and ‘thank you’/beer, thank you/beer, thank you/beer») e un arrangiamento in cui il nostro percorre, con la libertà di un jazzista, tutti i sentieri consentiti dalla tradizione americana. La seconda è, più semplicemente, il genere di canzone che si aggrappa alla tua gola e ti impedisce di respirare, il genere di canzone che Bill Callahan sa percorrere con grazia preziosa e rara.
 2. Low “The Invisible Way”
2. Low “The Invisible Way”
Etichetta: Sub Pop
A due anni di distanza da “C’Mon”, i Low tornano con un disco che suggella i venti anni di carriera e lo fanno affidandosi alla produzione di Jeff Tweedy, che, in modo discreto e allo stesso tempo rigoroso, affianca il proprio gusto per la ‘povertà’ del suono alla nudità espressiva di Alan Sparhawk e soci. Il risultato è un disco di grande impatto emotivo, crudo quanto basta, un disco di canzoni ampie come voragini esistenziali ma capaci di richiudersi in un abbraccio melodico che stringe il cuore dell’ascoltatore. Lavorando di sottrazione, arrivando all’osso delle composizioni, Sparhawk e Tweedy trovano una linfa vitale che dona nuovo ossigeno al folk delle origini. Clarence White, con le sue venature soul, è un eloquente esempio del tipo di perfezione di cui i ragazzi sono capaci. Quando poi è Mimi Parker a cantare (succede in ben cinque brani, un record per i Low), arrivano forse le carte più luminose e sorprendenti giocate da “The Invisible Way”: So Blue e Just Make It Stop sono brani che oltrepassano i confini dello slowcore per arrivare a chiunque, potendo appartenere senza problemi tanto al repertorio degli stessi Wilco quanto a quello dei Belle & Sebastian.
 3. Nick Cave & the Bad Seeds “Push The Sky Away”
3. Nick Cave & the Bad Seeds “Push The Sky Away”
Etichetta: Bad Seed Ltd / Mute
Può suonare strano, ma “Push The Sky Away” è la più piacevole sorpresa dell’anno, specie se si considera che il precedente “Dig!!! Lazarus Dig!!!” e i due dischi firmati Grinderman non si erano rivelati all’altezza di una delle più importanti discografie di ambito rock e soprattutto se si pensa all’abbandono di Mick Harvey, braccio destro di Cave sin dagli esordi australiani. Dopo la perdita di Blixa Bargeld (avvenuta ormai dieci anni fa) l’addio di Harvey poteva equivalere ad un’eutanasia per i Bad Seeds. Smentendo i pronostici “Push The Sky Away” è, invece, un lavoro scolpito nella polvere, scritto da una penna ispirata e messo in musica con un preciso disegno: restituire alla parola la propria forza sgretolante e vestirla con gli abiti più severi del guardaroba. “Push The Sky Away” raccoglie quanto seminato da Nick Cave e Warren Ellis nelle tante colonne sonore firmate negli ultimi anni e ognuna delle nove nuove canzoni potrebbe essere il motivo portante di un western apocalittico o suggellarne i titoli di coda. Dal torbido racconto di Water’s Edge alla sacralità malata di We real cool, dalla velvetiana Jubilee Street all’allucinata title-track, “Push The Sky Away” ci lascia con la certezza che, anche negli anni a venire, la canzone d’autore dovrà fare ancora i conti con Nick Cave.
 4. Mark Kozelek & Jimmy LaValle “Perils From The Sea”
4. Mark Kozelek & Jimmy LaValle “Perils From The Sea”
Etichetta: Caldo Verde
Mark Kozelek fa parte di quella generazione di musicisti americani baciata dalla grazia creativa e dal tormento esistenziale, la stessa di Elliott Smith e Kurt Cobain, ma, pur avendo avuto sin dagli esordi con i Red House Painters il supporto della critica, non ha mai raggiunto il grande pubblico e oggi è uno dei segreti meglio custoditi dell’indie d’oltreoceano. Affidando completamente, stavolta, le musiche e gli arrangiamenti alle mani esperte di LaValle (The Album Leaf), Kozelek si è concentrato sulle liriche e ha praticato una tale vivisezione della propria anima da lasciare senza fiato. Non inganni la soleggiata copertina, i toni sono quelli della folktronica più cupa e minimale. Dall’andamento ciondolante di Gustavo alla sussurrata He Always Felt Like Dancing, “Perils From The Sea” è un disco privo di orpelli, scarno eppure vivo di un amore impossibile, una raccolta di undici brani lunghi, ipnotici, che sanno divincolarsi dalla forma canzone per abbracciare un deserto musicale fatto di monologhi dell’anima e di una meravigliosa estetica della sconfitta.
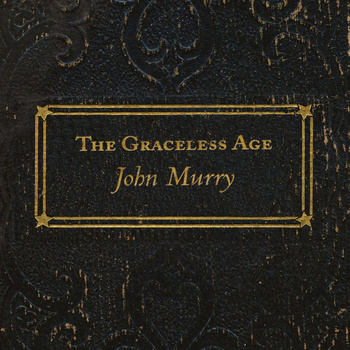 5. John Murry “The Graceless Age”
5. John Murry “The Graceless Age”
Etichetta: Rubyworks / Pias
Questo disco è uscito in sordina sul finire del 2012, ma visto che è stato ripubblicato quest’anno con l’aggiunta di alcune bonus track e che, in questa versione allungata, ha potuto godere di una migliore distribuzione, non esitiamo affatto a metterlo nella top ten del 2013, perché raramente si assiste in ambito rock ad un’operazione a cuore aperto come quella realizzata da John Murry. Figlio della migliore tradizione springsteeniana, con un timbro di voce che ricorda quello di Jay Farrar (Uncle Tupelo, Son Volt), prigioniero di demoni non più docili di quelli di Mark Lanegan, John è un trentaquattrenne di Tupelo, Mississippi, che ha lottato e continua a lottare contro le più brutte dipendenze, compresa quella da eroina. Ha perso tutto, moglie, figli, casa; gli è rimasta la musica, coltivata, accudita e abbracciata con forza. Le sue canzoni portano le stigmate della droga, ma sanno anche essere liberatorie e toccare la bellezza assoluta. Come Little Colored Baloons (il titolo fa riferimento alle bustine d’eroina, come ben si intuisce nel testo: «little colored balloons/a black nickel/a needle and a spoon/I know you don’t believe in magic/nobody does/not anymore»), l’instant classic della raccolta, dieci minuti di dolore pianistico che mescola le maestose ballate dello Springstenn anni Settanta con il senso di sconfitta cantato dagli American Music Club o, in anni più recenti, da Micah P. Hinson. Capolavoro tossico.
 6. Villagers “{Awayland}”
6. Villagers “{Awayland}”
Etichetta: Domino
Secondo album per l’irlandese Conor O’Brien dopo il debutto del 2010, “Becoming A Jackal”, che gli era valso paragoni lusinghieri. D’altra parte la somiglianza con i migliori esponenti dell’emo-folk adolescenziale – Bright Eyes su tutti – era evidente. Oggi lo è meno. “{Awayland}” si avventura in territori inesplorati, complice il maggior peso specifico dei musicisti che accompagnano Conor, il tastierista Cormac McCurran, il chitarrista Thomas McLaughlin e il batterista James Byrne. Mentre i testi continuano a raccontare la ferita senza fine che è la giovinezza, a volte con immagini bizzarre, come in Passing A Message («I was carving my name out of a giant sequoia tree/I was blind to its beauty now it’s all I can see »), altre volte con lapidaria disillusione, come nel singolo Nothing Arrived («I waited for something/and something died/so I waited for nothing/and nothing arrived»), le trame musicali si infittiscono e, tra drum machine, riverberi, dilatazioni radioheadiane e inserti kraut, il risultato è eccellente.
 7. Mavis Staples “One True Vine”
7. Mavis Staples “One True Vine”
Etichetta: Anti-
“One True Vine” raccoglie dieci canzoni che attraversano la tradizione musicale americana come un fiume di creatività in piena, mescolando gospel, soul, r’n’b, funk, alt-country, rock e reinventandoli con una passione che dalle parti del Loft di Chicago, lo studio di proprietà dei Wilco, non è mai doma. Già, anche qui c’è Jeff Tweedy in cabina di regia. La scaletta, aperta da un’intensa Holy Ghost, presa in prestito proprio dal recente album dei Low, alterna riletture e canzoni inedite. Can You Get To That e I Like The Things About Me portano la firma rispettivamente dei Funkadelic e del papà di Mavis, Roebuck “Pops”. A splendere sopra gli altri ci sono, però, i tre pezzi firmati da Jeff, che, se da un lato sembrano insuperabili già dopo un solo ascolto, dall’altro non si può fare a meno di immaginare rivoltati dalla chitarra di Nels Cline e dalla batteria di Glen Kotche in ipotetiche versioni live della band madre: Every Step, Jesus Wept e One True Vine, sono i vertici assoluti dell’album.
 8. Phosphorescent “Muchacho”
8. Phosphorescent “Muchacho”
Etichetta: Dead Oceans
Matthew Houk non può più nascondersi. Con “Muchacho” i suoi Phosphorescent sono arrivati al sesto album e i tempi sono più che maturi perché la sua musica si emancipi dal confinamento del culto. Quella dei Phosphorescent è Americana della più aggraziata e sublime specie. Lo sa bene chi ha amato “Pride”, l’album del 2007, chi è rimasto stupito dall’abilità di rileggere Willy Nelson in “To Willie” e chi ancora continua ad ascoltare e riascoltare quel capolavoro di “Here’s To Taking It Easy” del 2010. E lo saprà bene chi scoprirà i Phosphorescent con “Muchacho”, un disco dominato da un impressionismo country fatto di piccoli tocchi che materializzano allusioni e silenzi, lontananze e riavvicinamenti. L’iniziale Sun, Arise! è un mantra in perfetto stile Houk, arricchito però da un piano digitale che mette subito in chiaro come il musicista dell’Alabama stavolta, pur non abbandonando la tradizione, si sia divertito a sperimentare. Nella medesima direzione vanno le fiammate di Song For Zula e Ride On / Right On, quest’ultima vicina a certe bizzarrie alla M. Ward. La sintesi di vecchio e nuovo si trova nei sette minuti di The Quotidian Beasts, dentro i quali si sono date appuntamento le anime spezzettate di Will Oldham, Robbie Robertson e Neil Young.
 9. Rokia Traoré “Beautiful Africa”
9. Rokia Traoré “Beautiful Africa”
Etichetta: Nonesuch
“Beautiful Africa” è il disco della lontananza dal continente africano, e dal Mali in particolare. Rokia Traoré si è infatti rifugiata a Parigi a causa della guerra civile che insanguina il suo Paese e, distante dalle radici, è riuscita a scrivere canzoni piene d’amore e malinconia sì, ma anche di ritmo e vibrazioni positive. Le nove tracce di “Beautiful Africa” sono un caleidoscopio di colori, che pur mantenendo intatta la matrice world, non disdegnano di amoreggiare con il rock. Dunque spazio alle chitarre, con Stefano Pilia dei Massimo Volume ospite d’onore. Ci sono anche Sebastian Rochford dei Polar Bear alla batteria e, a infiocchettare e garantire il tutto, la produzione griffata John Parish, il mago dei suoni di PJ Harvey. “Beautiful Africa” è un disco che non può non funzionare, tra un’ipnotica Lalla, una contagiosa Mélancolie, una funkeggiante e, soprattutto, le struggenti Ka Moun Kè e Sarama.
 10. Califone “Stitches”
10. Califone “Stitches”
Etichetta: Dead Oceans
Scegliendo, per la prima volta, di registrare vagabondando per diversi studi tra California e Texas e affidandosi a più produttori, il rischio era quello di perdere l’amalgama sonoro che i Califone erano sempre riusciti ad ottenere con i precedenti lavori. Anche con “Stitches”, invece, Tim Rutili e soci sono ancora capaci di strappare applausi convinti. Per un disco del genere una volta si sarebbe usata la formula “disco di transizione”. Significativa è l’(apparente) leggerezza con cui le tonalità plumbee lasciano in più di un episodio spazio a squarci di sereno, così come non passano inosservati gli ulteriori passi di avvicinamento nei confronti di un’immediatezza discreta ma a tratti quasi radiofonica, se mi si concede il termine a proposito di una band aliena come i Califone. L’open track, grandiosa sin dal titolo (Movie Music Kills a Kiss), è il continuo riannodare i lacci della tradizione, con il ricamare del pianoforte a spazzare via la polvere. Colpiscono positivamente anche la contagiosa solarità di Frosted Tips, l’incedere ipnotico di Bells Break Arms e una ballata arricchita da archi meravigliosi, Moses. Poi c’è A Thin Skin Of Bullfight Dust, che è, semplicemente, il disegno di una perfezione assoluta.