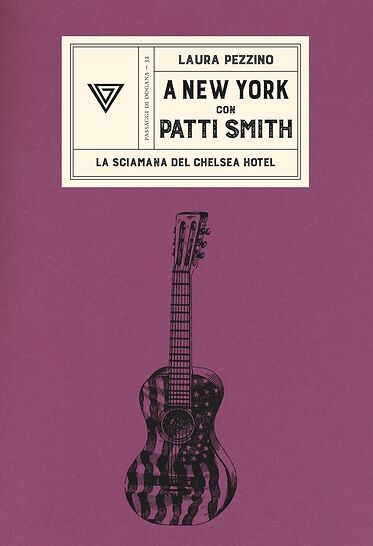Per l’editore Giulio Perrone è appena uscito un interessante volume, “A New York con Patti Smith”, in cui la giornalista Laura Pezzino percorre le strade della Grande Mela avendo in mente la biografia della poetessa del rock. Una topografia musicoletteraria che non mancherà di appassionare il fan dell’autrice di “Horses” e lo costringerà a giocare con la Street View di Google Maps per orientarsi tra strade e posti carichi di mito.
Il tuo vero incontro con Patti Smith è stato con la scrittrice invece che con la musicista. E’ stato il memoir “Just Kids” a toccarti nel profondo. Cosa significa? E ha senso secondo te usare questa distinzione di comodo tra la scrittrice (e la poetessa) e la musicista?
Conoscevo Patti Smith come tanti, per le sue canzoni più popolari, ma sapevo pochissimo di lei e della sua vita. Poi all’inizio del 2014, durante le vacanze di Natale, decisi di leggere il suo “Just Kids” e allora avvenne qualcosa, quello che definirei un incontro, o meglio un riconoscimento. Per usare una sua espressione, riconobbi una «fratellanza della bohème», quella che lei provò a sedici anni vedendo per la prima volta il volto di Rimbaud su un libretto, che era “Illuminazioni”, sul tavolo di una bancarella di Philadelphia. O quella che sentiamo quando incontriamo quelle persone che nella nostra vita conteranno moltissimo. Un sentimento, una rivelazione. Per me lei sarà sempre una poetessa, perché credo lo sia stata prima di diventare musicista e performer. È come la distinzione tra vocazione e talento: la sua vocazione è quella di poeta, il suo talento quello di essere una straordinaria performer, in grado di liberare balli alle prime note di People Have The Power o Gloria.
In effetti l’amore per i libri per Patti nasce prima dell’amore per i dischi, non a caso a New York i suoi primi lavori sono tutti in una libreria e ancora oggi le librerie sono i luoghi che frequenta più volentieri. Che tipo di legame c’è tra Patti e i (suoi) libri?
Un legame inscindibile. Patti, lo ha detto lei stessa, legge sempre, in qualsiasi situazione. E anche oggi, sul suo account Instagram, i libri sono i protagonisti. Quando, durante l’intervista che le ho fatto, le ho chiesto se legge anche testi appena usciti, lei mi ha risposto che preferisce leggere e rileggere i suoi amati autori, Sebald, Plath, i russi, Rimbaud, Dylan Thomas, ma anche Ditlevsen e i sudamericani. Credo che nella lettura non vada alla ricerca di nuove relazioni, ma che leggere sia per lei un modo di rincontrare vecchi amici, amici più grandi di lei che non finiscono mai di dirle qualcosa di folgorante. Una volta raccontò del suo incontro con Murakami, uno degli scrittori più amati, e lo descrisse con la stessa autentica emozione con la quale io stessa potrei descrivere il mio incontro con lei o con una delle scrittrici che hanno dato forma alla me lettrice.
E dove credi risieda la natura ultima della contaminazione tra musica e letteratura che è una costante della sua arte, così riuscita e così felice se paragonata all’opera di molti altri musicisti letterati?
Patti, grazie a sua madre Beverly, è stata una bambina innamorata dei libri, “Alice nel Paese delle meraviglie”, “Pinocchio”, “Peter Pan”. Da piccola, dormiva con i libri sotto il cuscino per assorbirne le parole durante la notte. Poi sono arrivati i poeti, Rimbaud, Blake, Baudelaire. Al Chelsea Hotel, mentre sostava in quella hall che fu per lei un vero e proprio stargate a osservare e studiare tutti quelli che entravano e uscivano, erano i poeti e gli scrittori ad affascinarla di più. Venerava Ginsberg, Burroughs, Corso. Poi, chiaramente, tra i suoi punti di riferimento ci sono stati anche quei musicisti, come Bob Dylan, che sanno fondere in modo naturale note e parole (non a caso gli hanno dato un Nobel, ritirato da Patti, tra l’altro, per via della lunga amicizia che li unisce). Ha iniziato a comporre le prime poesie che era già adulta, in uno dei quadernetti da cui non si separava mai e che aveva portato anche a Parigi, la sua città più sognata dopo New York. Quando, al Ex Quijote, incontrò Bob Neuwirth che le chiese di scrivere una canzone, il suo primo istinto fu quello di adattare una delle sue poesie. Ho raccontato tutto questo per dire che, più che di contaminazione, mi viene quasi da parlare di fecondazione: la poesia che era dentro di lei è riuscita a fecondare tutto il resto, la sua vita, i suoi amori, la musica, l’arte, i rapporti.
Il tuo libro è un modo per misurare la distanza tra la New York del 1967, quando Patti Smith arriva in città, e la New York di cinquantacinque anni dopo. E’ una distanza per certi versi molto evidente, ma è una questione di punti di vista. Spostando un po’ la visuale, la New York di oggi porta dentro di sé tracce indelebili della New York che non c’è più, posti e personaggi che pur non essendoci fisicamente continuano a vivere con una forza che si percepisce dappertutto.
Sono convinta che niente vada perduto e che tutto si trasformi. Lo diceva Lavoisier nel Settecento e molto prima di lui Eraclito, che nel V secolo prima di Cristo fondò la teoria del movimento, per la quale, semplificando molto, non ci possiamo mai bagnare nello stesso fiume perché un istante dopo averlo fatto né noi né il fiume siamo già più gli stessi. Se ci pensiamo, d’altra parte, tutto ciò che esiste – noi stessi compresi – proviene dal quell’unica, per noi inimmaginabile, esplosione primigenia di gas e materia interstellare alla quale oggi un nuovo potentissimo telescopio a infrarossi sta cercando di avvicinarci un po’ di più. Quindi, la New York di oggi è e non è la stessa, ha perso delle cellule ma ne ha acquisite altre. Passare sotto al Chelsea Hotel assediato dalle impalcature. Prendere la metropolitana fino a Coney Island. Attraversare il Washington Square Park. Entrare nello Scribner Building sulla 5th Avenue. Costeggiare le rovine dell’antico ospedale di Roosevelt Island. Sono tutti modi di ripercorrere i passi di Patti Smith e di chi era con lei cinquant’anni fa, e se ci concentriamo intensamente, se ci mettiamo in ascolto, possiamo ancora sentirli. È quel miracolo chiamato memoria.
Dopo un lungo periodo di assenza, dopo il matrimonio con Fred Sonic Smith e dopo la morte improvvisa di quest’ultimo, Patti torna a vivere a New York. Ormai sono gli anni novanta e alla città sporca e pericolosa dei settanta se ne è sostituita una più vivibile ed edulcorata, ma non per questo meno stimolante ed elettrica. Come si misura la distanza di cui stiamo parlando dal punto di vista di Patti Smith che ritorna dopo essere stata a lungo lontana?
Posso soltanto immaginare, perché Patti non si è espressa esplicitamente su questa distanza. Nel 1996, quando decide di ritrasferirsi a New York in seguito alla morte di Fred, la città è decisamente cambiata. E non solo perché tutto cambia in continuazione. Mentre lei viveva a Detroit e cresceva i suoi due bambini, Jackson e Jesse, l’Aids aveva spazzato via quasi un’intera generazione di artisti, compreso il grande amore della sua gioventù Robert Mapplethorpe. La musica e i gusti, anche, sono cambiati, e in effetti i dischi che fa da quel momento in poi non hanno il successo dei precedenti. Ma soprattutto, è lei a essere diversa. Come saranno stati i suoi occhi? Come le sarà parsa New York? Io penso che, nonostante tutto, si sia sentita accolta da questa città ancora una volta, e non è un caso che abbia poi deciso di non lasciarla più.
Ti va di parlare nello specifico di quelli che tu hai definito rifugi/trampolini per Patti?
Sì, uno è stato di sicuro il Chelsea Hotel, con il suo magico antro e quella concentrazione unica nella Storia di personalità geniali in un numero spropositato di discipline artistiche. Un altro è stato il Poetry Project, il collettivo, tuttora attivo, che negli anni ha calamitato tutti i maggiori poeti, non solo americani. Credo anche che, in un certo senso, la stessa storia d’amore con Robert Mapplethorpe abbia funzionato da catalizzatore: avere incontrato una persona che, come lei, era affamata di espressione penso abbia influito molto sulla sua evoluzione artistica.
Legato al Chelsea Hotel è il capitolo, per me uno dei più belli, intitolato “La strada del vento”, in cui percorri da est verso ovest la ventitreesima fissando i punti di interesse pattismithiani in una carrellata irresistibile.
Sono contenta ti sia piaciuto, perché l’idea di raccontare quella strada, la 23rd, camminandola mi è arrivata all’improvviso come un colpo di vento, quando un amico mi raccontò un aneddoto, che poi ho scoperto essere inesatto, su Scorsese e New York. Non avevo idea che in quella manciata di isolati si potessero ritrovare così tante tracce del passaggio newyorkese di Patti, però ho seguito l’intuizione iniziale e, in effetti, ne ho scoperte tantissime. Alcune più forti e dirette, come il Chelsea Hotel, altre indirette, come la chiesa in cui si era sposata Edith Piaf, una delle prime cantanti che aveva ascoltato a casa assieme a suo padre Grant e che aveva amato molto fin da allora. Mentre camminavo, poi, sono nate le deviazioni che, devo dire, sono le mie parti preferite di quel capitolo, perché nella vita succede proprio così: mentre stai andando a visitare il Chelsea Hotel vedi un coniglio bianco che si infila in una strada laterale e non puoi fare a meno di inseguirlo.
Un altro rifugio/trampolino è stato il CBGB, un’icona che per gli appassionati di punk-rock non ha certo bisogno di presentazioni.
Purtroppo il CBGB ha chiuso nel 2016 e non mi pentirò mai abbastanza per non essere andata a visitarlo almeno una volta. Per questo, scrivendo quella parte del libro, ho sentito la necessità di sentire chi quei luoghi li avesse vissuti di persona. Non è stato semplice, perché si parla di almeno 50-40 anni fa. Poi grazie a un’amica sono arrivata a Philippe Marcade, con il quale ci siamo scambiati una serie di email molto divertenti. Lui arrivò proprio nella prima metà degli anni Settanta, nel momento in cui il punk aveva iniziato a circolare in città. Lui stesso ha suonato per vent’anni nei Senders, e ha conosciuto praticamente tutti, Patti Smith compresa. Devo dire che le parti del libro in cui lo faccio parlare mi fanno ridere fino alle lacrime. Se ci ripenso, rido anche adesso!
Hai immaginato il libro anche come un invito a leggere (per chi non li conoscesse) o a rileggere (per chi li conosce già) autori come Allen Ginsberg, Hubert Selby Jr, Jim Carroll, Gregory Corso, Gay Talese, etc?
Mi sono accorta che è qualcosa che faccio spesso, aprire parentesi letterarie e riferimenti ad autori altri. Viviamo immersi nelle storie e nelle parole che abbiamo letto nel corso della nostra vita, ed è normale che si accendano continuamente lucine nuove che fanno aumentare l’estensione delle nostre costellazioni. Quella di fare collegamenti e rimandi, di invitare a leggere e conoscere di più (un invito che faccio in primo luogo a me stessa), è un’abitudine che mi porto dietro fin da quando ero bambina e la mia vittima era mia sorella minore, che invece voleva semplicemente giocare con le bambole. Sono, ovviamente, un’avida consultatrice delle bibliografie altrui. Se un libro, soprattutto se non è un saggio puro, ha una bella bibliografia finale per me ha qualcosa in più. Come scrive Elena Ferrante ne “I margini e il dettato”, il suo ultimo libro, che è complesso e bellissimo e, appunto, da leggere, «scrivere e? accomodarsi in tutto cio? che e? gia? stato scritto – la grande letteratura e quella di consumo, se serve, il romanzo-saggio e la sceneggiata – e farsi, nei limiti della propria vorticosa, affollata, individualita?, a propria volta scrittura». E quindi sì, penso che se a ogni lettore di questo libro color ciclamino venisse voglia di andarsi a guardare almeno uno dei titoli o degli autori che ho citato, ecco, sarei una persona molto felice.