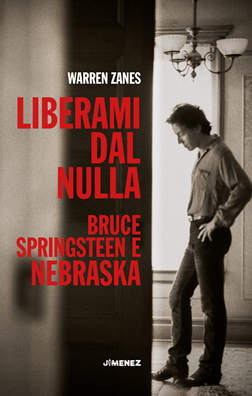«È un documento talmente intimo che stupisce che il suo autore abbia fatto ascoltare il nastro a qualcuno, figuriamoci pubblicarlo come album», scriveva nel 1982 il critico Joel Selvin recensendo “Nebraska” per il San Francisco Chronicle. E poi ancora: «Su questo disco Springsteen inciampa spesso in tempo e metrica, a tratti mormora versi indistinti e più in generale include segni casuali e momenti di umana fallibilità che chiunque altro si sarebbe preso del tempo per eliminare. Non che Springsteen sia pigro, anzi, l’ovvia intenzione del suo lavoro è permettere all’ascoltatore di assistere a un momento di fragilità del processo creativo che non è possibile ricatturare… Mai in precedenza un artista su major si è mostrato così vulnerabile e si è aperto così tanto».
Si può raccontare Bruce Springsteen in molti modi, ma uno dei migliori è sicuramente quello di decifrarlo attraverso i suoi dischi. Warren Zanes, scrittore, giornalista ed ex chitarrista dei Del Fuegos, ha scelto di raccontare Springsteen partendo da un suo album, “Nebraska”, il più anomalo e tetro della sua discografia. Con la precisione di un entomologo dell’industria rock dei primi anni Ottanta, con competenza, passione e quel tot di prolissità che gli appassionati di musica quasi mai disdegnano, nel suo pregevole libro “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska” appena pubblicato da Jimenez, Zanes ricostruisce nel dettaglio i vari momenti che hanno portato alla nascita del disco, alla sua registrazione casalinga e alla decisione di pubblicarlo così com’era: ciascuno di tali passaggi, avvenuti con questa consequenzialità ma non con la leggerezza e la velocità con cui vengono elencati, risultarono oltremodo lenti e sofferti e furono affrontati da uno Springsteen alle prese con il periodo forse più difficile della sua vita.
Finito il tour di “The River”, l’artista faticava a trovare il suo posto nel mondo, non sapeva più quale fosse casa sua. Aveva raggiunto un riconoscimento enorme ed era destinato, anche se lui non poteva ancora saperlo, ad un successo ancora più grande. Il successo non era però la sua zona di comfort. Il palco lo era sicuramente, l’automobile e il tour bus lo erano, il one two three four con cui liberava il rock’n’roll lo era, ma non il successo, per quanto lo avesse perseguito in modo anche ossessivo.
La genesi di “Nebraska” coincise con il periodo in cui Springsteen fece di tutto per diventare latitante, per scomparire dai radar e ritrovarsi in una desolazione assoluta. Si trattava di un viaggio al termine del buio per il rocker del New Jersey, che doveva affrontare un crollo emotivo di cui avrebbe rivelato l’entità soltanto anni dopo, un viaggio in un luogo a cui è stato dato il nome Nebraska ma che avrebbe potuto benissimo chiamarsi oscurità, solitudine, vuoto, nulla – «liberami dal nulla» – un luogo che, una volta visitato, lo avrebbe trasformato per sempre. Come scrive Zanes, «l’esperienza di “Nebraska” si era avvinghiata a Springsteen come una specie di residuo psichico». Dopo aver preso in affitto una casa a Colts Neck, a metà strada tra Asbury Park e la natia Freehold, e trovato accogliente la stanza da letto con la moquette arancione a pelo lungo, Springsteen registrò in totale solitudine, con l’aiuto di un 4 tracce Teac 144, un pugno di brani con cui si addentrava nel lato più spaventoso del sogno americano, nel suo rovescio, e con cui ritornava all’infanzia e ai fantasmi del suo passato più che con tutte le altre canzoni che aveva fin lì scritto. «Mansion On The Hill era solo un ricordo d’infanzia», ha detto Springsteen, «ma mi permise di affrontare i conflitti che percepivo».
Mansion On The Hill fu il primo brano a venire fuori e poi, in breve tempo, arrivarono gli altri, Nebraska, Atlantic City, Johnny 99, Highway Patrolman, State Trooper, Used Cars, Open All Night, My Father’s House, Reason To Believe. Erano canzoni piene di presenze inquietanti, dell’indicibilità del rimosso, ma con una struttura narrativa spesso impeccabile da renderle dei micro-racconti (o dei micro-film: non è un caso che Sean Penn usò come soggetto per “Lupo solitario”, il suo primo film da regista, il testo di Highway Patrolman). Non erano canzoni pensate per rimanere al loro stadio primordiale, l’idea di Springsteen era quella di portarle in studio per registrarle con la E Street Band. Fu subito chiaro però che il lavoro con gli altri musicisti produceva risultati che non rendevano giustizia all’atmosfera un po’ magica e un po’ sinistra della cassetta da un dollaro registrata a casa – fu subito chiaro quanto meno ad uno Springsteen sempre più preda di un asfissiante senso di impotenza – e che per non perdere l’irripetibilità di quel momento non si poteva perseguire la strada della band. Il suono roboante di quest’ultima poco si addiceva a quelle composizioni cupe, ispirate dai racconti di Flannery O’Connor, dalle fotografie di Robert Frank e da “La rabbia giovane” di Terrence Malick. Le canzoni di Colts Neck non avevano dentro lo slancio di tante ballate springsteeniane né la forza travolgente di brani come Born To Run o Badlands, avevano invece «il suono di un uomo che tirava fuori a forza delle canzoni mentre una mano lo tratteneva brutalmente sott’acqua, tenendolo per il collo», dunque non potevano che rimanere così, raggelanti e nude, se non si voleva correre il rischio di depotenziarle o edulcorarle. E così furono pubblicate, con un’operazione anticommerciale che mai un artista di quel calibro aveva pensato di fare fino ad allora. «Springsteen ha realizzato il disco in un momento in cui le aspettative nei suoi confronti erano enormi», scrive Zanes, «a volte sembrava quasi che il rock’n’roll fosse una sua responsabilità». Ovvio che alla Columbia non festeggiarono quando il manager del Boss, Jon Landau, fece ricorso a tutte le sue doti diplomatiche non solo per far accettare il fatto che “Nebraska” fosse il successore di “The River” ma anche per spiegare che l’artista non voleva una promozione martellante, desiderava anzi che il disco fosse promosso soltanto il minimo indispensabile, e che non ci sarebbe stato alcun tour per presentare le nuove canzoni dal vivo. La Columbia, pur senza comprendere del tutto, digerì intelligentemente “Nebraska” e le condizioni di Springsteen, sapendo di avere tra le mani un artista autentico e allo stesso tempo uno che fin lì aveva avuto una carriera in crescendo; si trattava, per una volta, di non fare un passo in avanti bensì un passo laterale in una direzione sconosciuta, con la speranza che l’ascesa sarebbe ripresa con la mossa successiva, come poi effettivamente avvenne due anni dopo con la pubblicazione di “Born In The U.S.A.”.
Il 20 settembre del 1982, poche settimane prima che il settimanale Time eleggesse Uomo dell’Anno il personal computer, Springsteen pubblicò un album antitecnologico, lo-fi ante litteram, spoglio, sgranato e mixato a basso volume. Nella nascente era digitale, “Nebraska” rivendicò l’imperfezione dell’arte, svelando al contempo la faccia oscura del suo autore. La sua influenza fu enorme. Innumerevoli gli artisti che furono folgorati dall’esempio del Boss, dal semplice fatto che un disco del genere si potesse fare. “Nebraska”, con la sola forza di una voce, una chitarra acustica Gibson J-200 e un’armonica a bocca, sfondò muri su muri di preconcetti e ha continuato a farlo nel corso degli anni, spalancando la porta a tutti quegli artisti innamorati di un approccio do it yourself alla musica e alla sua registrazione. Come dice Matt Berninger dei National «è stato una specie di big bang per tutti quegli artisti indie rock che facevano la loro roba nella solitudine della propria cameretta».
Poi nel 1984 Springsteen pubblicò “Born In The U.S.A.”, blockbuster da trenta milioni di copie che lo trasformò nella più grande rockstar del pianeta; la title-track, nata ai tempi di Colts Neck ma poi messa da parte, divenne, grazie al martello pneumatico di Max Weinberg e al celeberrimo giro di tastiere di Roy Bittan, un inno tanto frainteso quanto incontenibile; dall’album furono estratti sette singoli, tutti entrati nella top ten di Billboard; il tour che ne seguì portò per la prima volta Springsteen in Italia, nel mitico concerto di San Siro del 21 giugno 1985. Ma niente di tutto ciò che accadde con “Born In The U.S.A.” sarebbe stato possibile senza “Nebraska”. Springsteen non sarebbe mai andato incontro alla gloria accecante del 1984, se non si fosse garantito la possibilità di rendersi invisibile all’occorrenza. «Avevo bisogno di sapere che potevo tornare indietro e non essere nessuno, se fosse stato davvero necessario», dice il Boss, «e, sì, a quel punto “Born In The U.S.A.” divenne possibile».
[Questo articolo è stato pubblicato sul blog letterario minima&moralia]